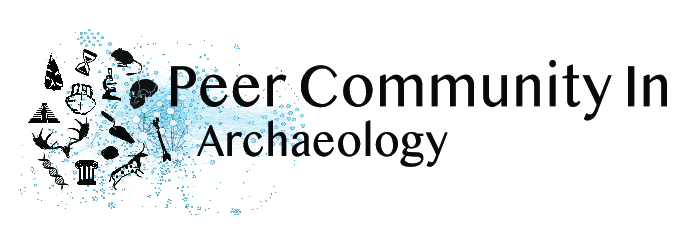A Marzano si festeggia San Terenziano (San Ransiàn) il 1° settembre o la prima domenica di settembre, anche se la chiesa di Marzano è dedicata a San Bartolomeo (che si festeggia una settimana prima, il 24 agosto).
Premesso che è comunque una generica “festa di fine estate”, è interessante notare che entrambi i santi sono protomartiri.
C’è una ricorrenza di associazioni tra San Terenziano e San Bartolomeo, anche se in località vicine: Rezzoaglio (GE) dove San Bartolomeo è festeggiato a Magnasco, Leivi (GE), Cavriago (RE). Tuttavia il culto di San Bartolomeo è molto diffuso in tutta Italia, mentre quello di San Terenziano è più raro.
Il sito www.encyclocapranica.it non è più online ma anni fa vi ho trovato questa interessante lista tratta da una pubblicazione a stampa (purtroppo non sembra archiviata nemmeno sulla Wayback Machine). La tematica è ripresa sul sito Capranica Storica sempre a cura di Massimo Brizzolara. Unica correzione apportata riguarda la località Rosso, che si trova in comune di Davagna e non di Lavagna.
- Recco (Comune di Recco, Arcidiocesi di Genova): si ricorda una cappella intitolata al Santo, mutata in San Rocco tra il sec. XV e il sec. XVI dopo una grave pestilenza (concomitante culto di San Rocco);
- Premanico (già appartenente al Comune di Apparizione, ora Comune di Genova, Arcidiocesi di Genova): esistono ruderi di chiesetta intitolata al Santo (concomitante culto di San Rocco);
- Pino (Comune di Genova, Arcidiocesi di Genova): chiesa parrocchiale intitolata a San Michele e Terenziano, patrono del luogo. Si ricorda il cosiddetto olio di San Terenziano, benedetto e distribuito alla popolazione in occasione della festa, che possiede virtù taumaturgiche per la cura dei reumatismi e delle artriti. Vi esiste anche una confraternita dal titolo dei Santi Michele e Terenziano;
- Rosso (Comune di Davagna, Arcidiocesi di Genova): località intitolata al Santo;
- Teriasca (Comune di Sori, Arcidiocesi di Genova): la locale chiesa di San Lorenza, fu originariamente edificata sotto il titolo dei Santi Lorenzo e Terenziano (concomitante culto di San Rocco);
- Fumeri (Comune di Mignanego, Arcidiocesi di Genova);
- Rezzoaglio (Diocesi di Bobbio-Piacenza): patrono del luogo (concomitante culto di San Rocco);
- Leivi (Diocesi di Chiavari): con cappella intitolata ai santi Terenziano e Desiderio;
- San Terenziano (Comune di Leivi): patrono del luogo;
- Nicorvo (Diocesi di Vigevano): patrono del luogo, con chiesa parrocchiale propria e chiesa rurale;
- Rompeggio (Comune di Ferriera Diocesi di Piacenza-Bobbio): patrono del luogo;
- Ebbio (Comune di Bettola Diocesi di Piacenza-Bobbio): patrono del luogo, con chiesa parrocchiale propria;
- Groppo Ducale (Comune di Bettola Diocesi di Piacenza-Bobbio);
- Isola di Compiano (Comune di Compiano Diocesi di Parma): patrono del luogo, vi si svolge una “Fiera Millenaria di San Terenziano” in occasione della festa;
- Gorro (Comune di Borgotaro Diocesi di Parma): patrono del luogo;
- Fraore (Comune di Parma Diocesi di Parma): patrono del luogo, con chiesa parrocchiale propria;
- Soragna (Diocesi di Parma): si ricorda una fiera in onore del Santo all’interno della Rocca;
- San Terenziano (Comune di Cavriago Diocesi di Reggio Emilia): con chiesa parrocchiale propria;
- Raiano di Cornio (Diocesi di Sulmona-Valva): con eremo dell’XI sec. intitolato al Santo;
- Capua (Arcidiocesi di Capua): si ricorda una chiesa intitolata al Santo, già nel XIII sec., fatta demolire da Federico II di Svevia per far posto all’edificazione della porta della Città;
- Tortona (Diocesi di Tortona): vi si ricorda un vescovo Terenziano, martirizzato nel 186 d.C., ma non è certo che sia lo stesso Terenziano di Todi;
- San Terenziano (Comune di Gualdo Cattaneo Diocesi di Todi): con chiesa parrocchiale e tomba del Santo;
- Teano (Diocesi di Teano): con reliquie (un braccio) ed officiatura approvata;
- Capranica (Diocesi di Civitacastellana): patrono del luogo, con reliquie (il cranio e un braccio), officiatura approvata e chiesa propria. Vi esiste una confraternita intitolata ai Santi Terenziano e Rocco;
- Todi (Diocesi di Todi): officiatura con lezioni proprie e rito doppio di II classe, festa celebrata nella Città e in tutto il territorio diocesano il 1° settembre di ogni anno.
Ho letto per la prima volta una sintesi con ipotesi storiche su questa diffusione riguardo a Rezzoaglio, un documento di qualche anno fa ma sempre molto interessante.
C’è una concentrazione del culto nell’Italia centrale e soprattutto nell’Appennino Ligure-Emiliano e Genovesato. Dall’elenco dei 25 luoghi, a cui si aggiunge Marzano, ho creato una mappa digitale. Certamente chi ha prodotto questo filmato ha usato lo stesso elenco. Altri riferimenti ma privi di elenchi sono sul sito santiebeati.it. Un elenco abbastanza completo è su CathoPedia. Tutti questi elenchi sono comunque incompleti, ma hanno il pregio di registrare notizie altrimenti difficili da reperire, un po’ come quella che associa San Terenziano a Marzano.

Dal punto di vista geografico, Marzano ricade pienamente nella zona di attestazione, anzi è quasi un punto di collegamento tra le presenze del versante ligure e quelle del versante padano.

Come abbiamo già avuto modo di vedere le notizie storiche su Marzano sono piuttosto scarne, ma a San Terenziano doveva essere già essere dedicata la prima cappella precedente alla chiesa.
Pillole di storia marzanina
La chiesa di San Bartolomeo · San Terenziano
Marzano 200 anni fa · La peste a Marzano nel 1656-1657