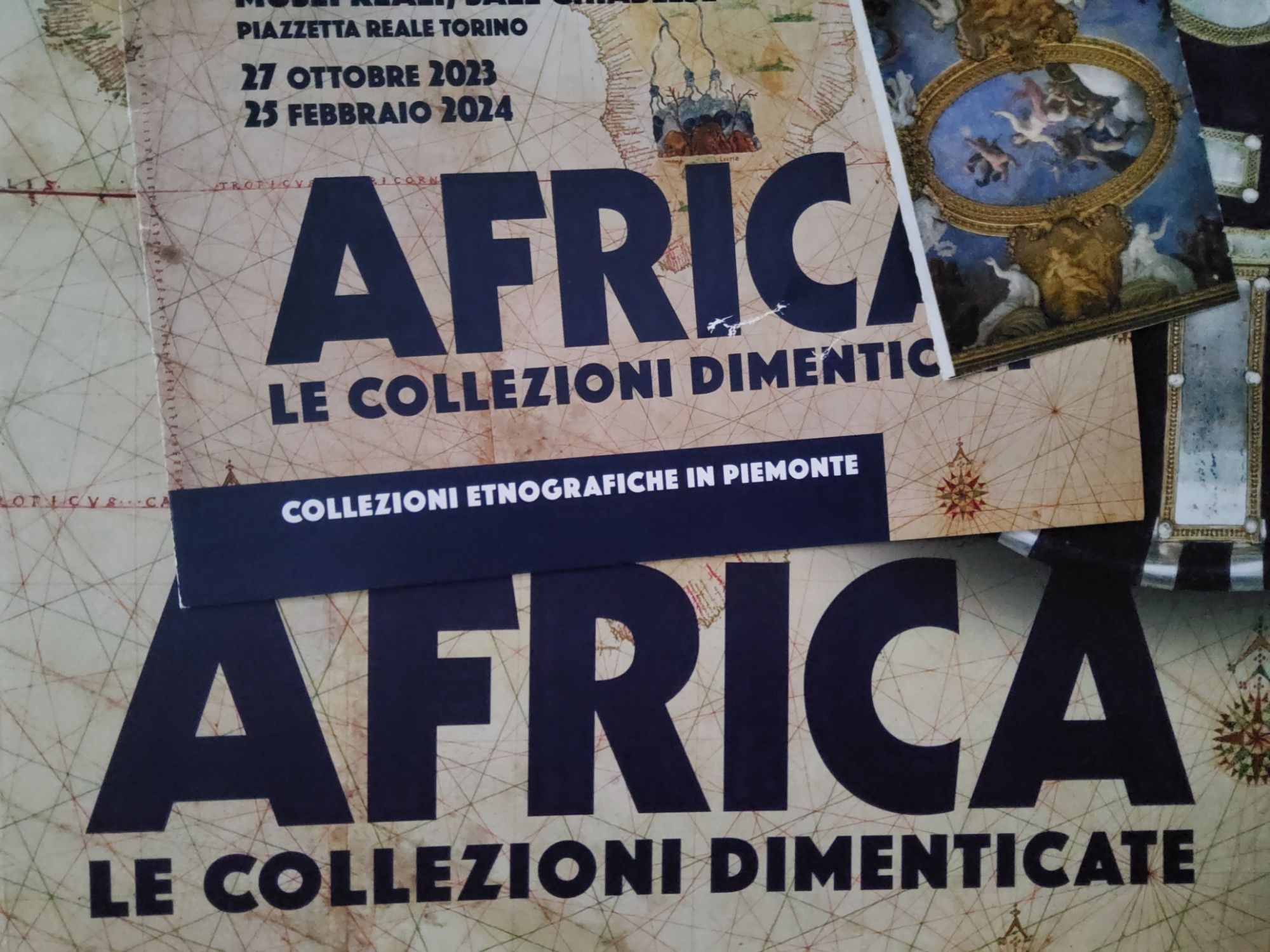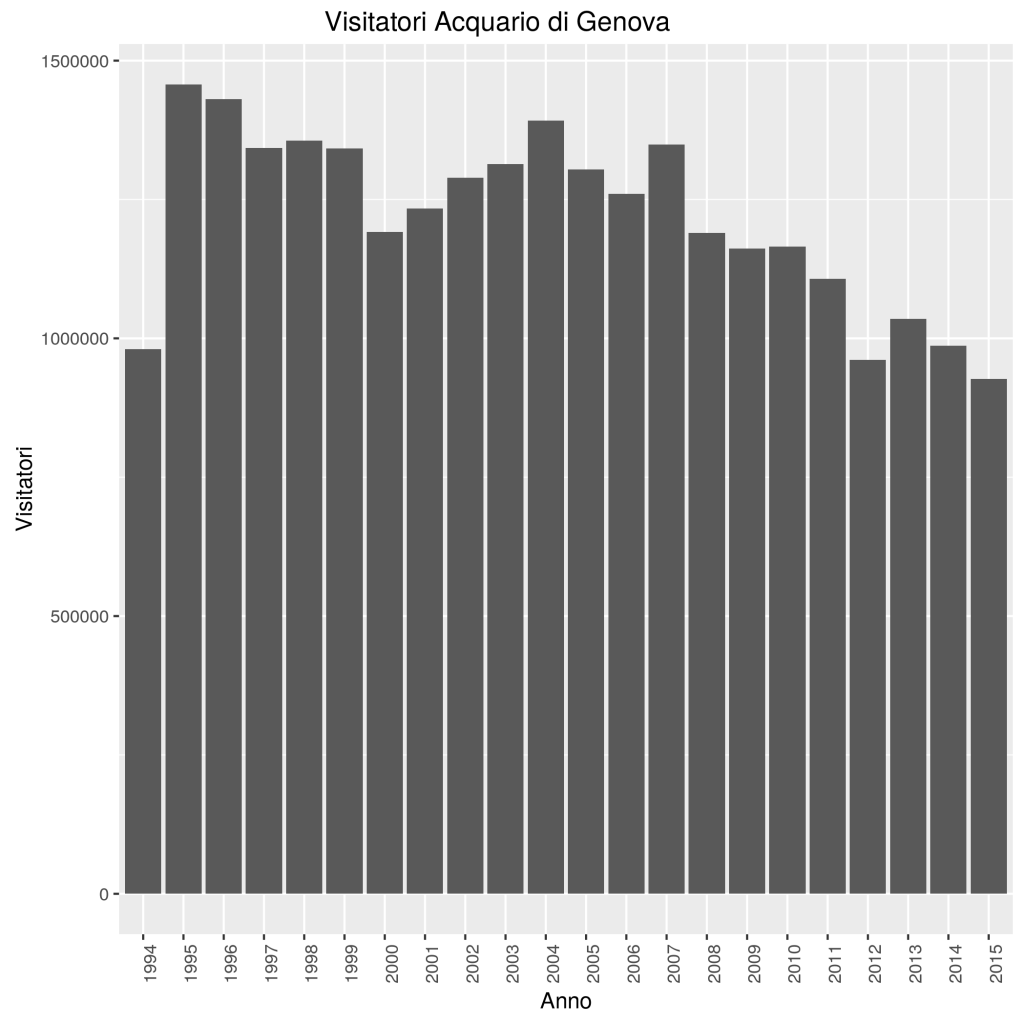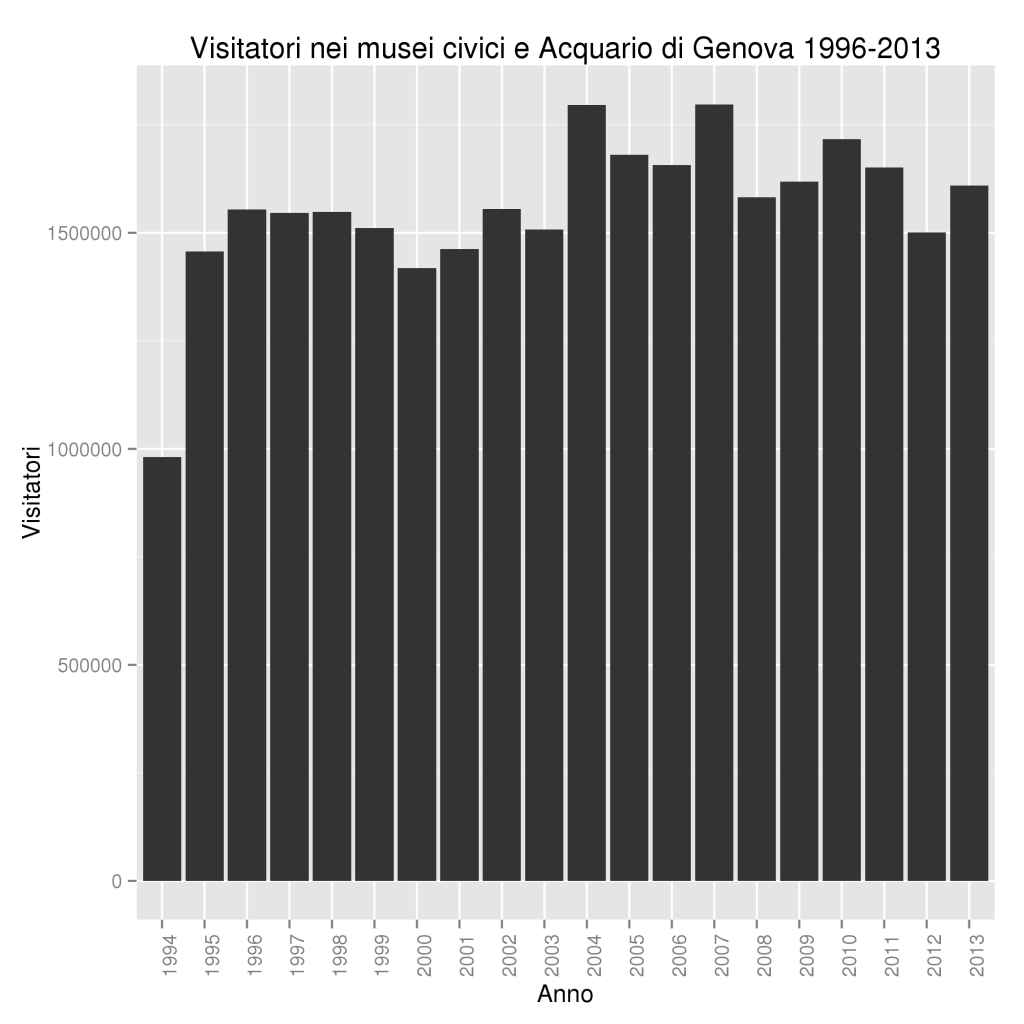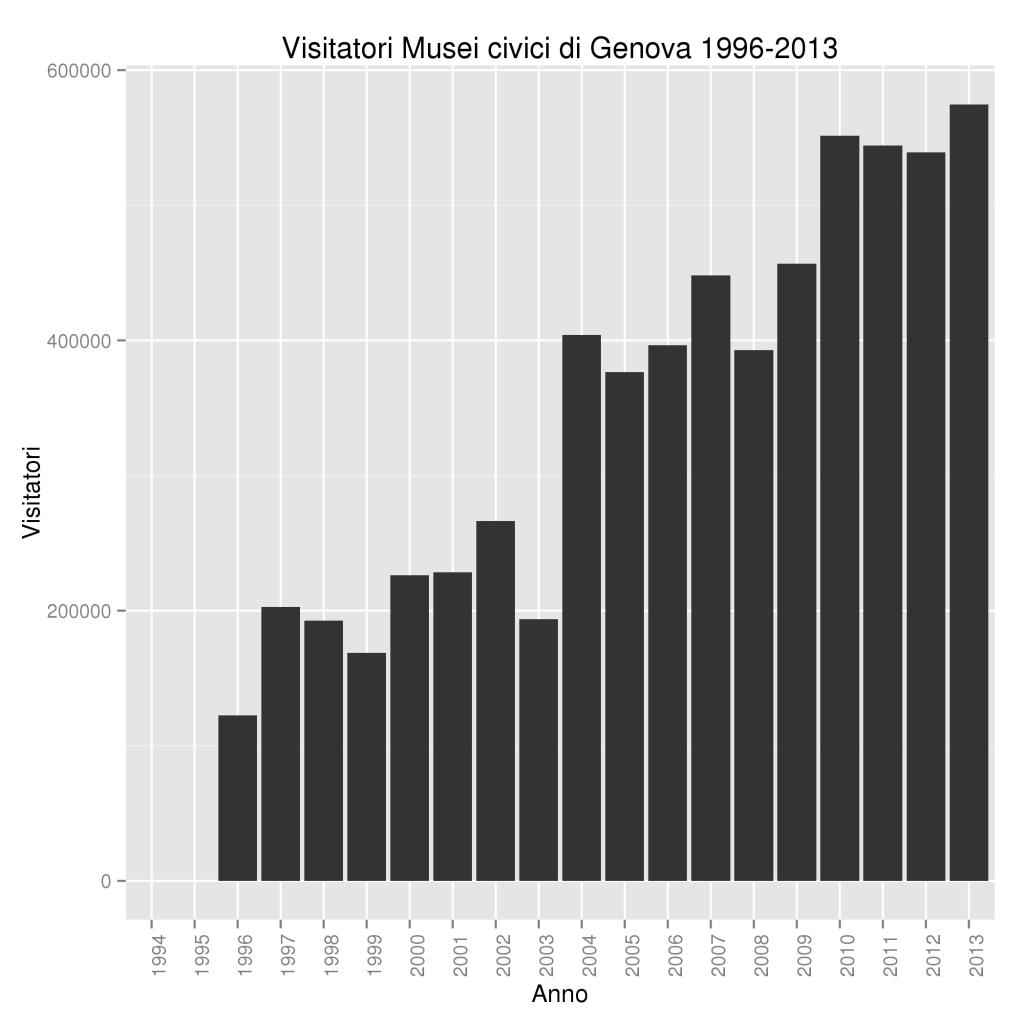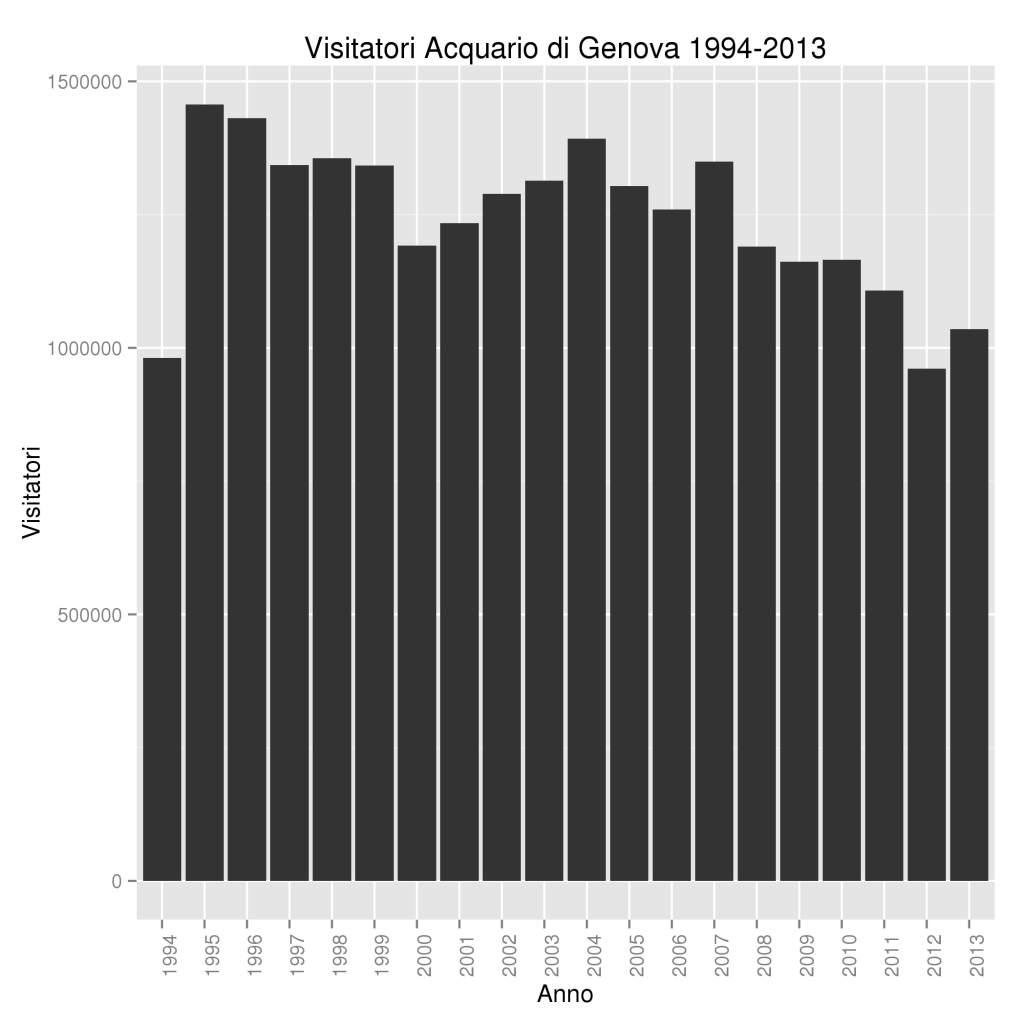È finita a Torino la mostra “Africa. Le collezioni dimenticate” allestita nelle sale di Palazzo Chiablese. Sono riuscito a visitare la mostra pochi giorni fa. Mi è piaciuta molto.
La mostra è stata organizzata dai Musei Reali di Torino, dalla Direzione Regionale Musei Piemonte e dal Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino, ed è una intensa passeggiata nel voyeurismo e collezionismo italiano durante il lungo periodo della scoperta, conquista e razzia dell’Africa, fino agli orrori della guerra in Etiopia. Il percorso si snoda sui passi di molti personaggi, tutti uomini italiani: esploratori, ingegneri al servizio dell’espansione belga nel Congo, affaristi, membri della casa reale. Tutti accomunati dall’attività coloniale nelle sue diverse fasi storiche, e tutti prontamente rimossi dalla memoria collettiva al termine della seconda guerra mondiale. Altrettanto dimenticate le collezioni di oggetti africani che questi personaggi hanno fatto confluire a vario titolo nei musei italiani e in questo caso piemontesi.
Ad accompagnare la visita le installazioni di Bekele Mekonnen, in particolare il “site specific” dal titolo “The smoking table” ma anche le clip sonore lungo il percorso.
La mostra ha agitato tantissimo i fascisti dichiarati e quelli non dichiarati perché non usa giri di parole, perché chiama il colonialismo e il razzismo con il loro nome, perché mette le voci africane sullo stesso piano di quelle italiane. Il ricco programma pubblico ha coinvolto molte persone, anche originarie dell’Africa.

Le polemiche, tutte politiche e ben poco culturali, suonano come un brusio fastidioso se consideriamo il lavoro lunghissimo di preparazione della mostra, la quantità di musei con collezioni africane in tutto il Piemonte, la ricchezza del catalogo che affronta in dettaglio molte delle questioni sollevate ad arte, ad esempio il salario pagato ai lavoratori della Società Agricola Italo-Somala, veri “forzati della terra” anche nelle parole degli italiani dell’epoca.
Il paradosso sta nel fatto che questa mostra è molto blanda, se la inquadriamo nella cornice europea e occidentale bianca dei musei di antropologia e archeologia: dalla complessa operazione di continuo adattamento del Musée du Quai Branly di Parigi, al documentario Dahomey di Mati Diop che ha vinto l’Orso d’oro del Festival di Berlino pochi giorni fa, per finire al lavoro avviato nel 2016 da quello che oggi si chiama Museo delle Civiltà. È molto eloquente l’intervento del direttore Andrea Villani a un convegno di poche settimane fa, che potete rivedere su YouTube. Ho apprezzato questo passaggio:
Quello che allora aveva un senso oggi può non solo non avere un senso, ma può anche essere tossico. [..] La storia non si cambia. I musei non cambiano la storia, ma possono raccontarla per intero, accettando di mettere in crisi quello che è venuto prima
E poiché in Italia non siamo solo colonizzatori ma anche colonizzati e depredati, è bene sapere che alcuni musei degli USA sono seriamente alle prese con la provenienza delle proprie collezioni.