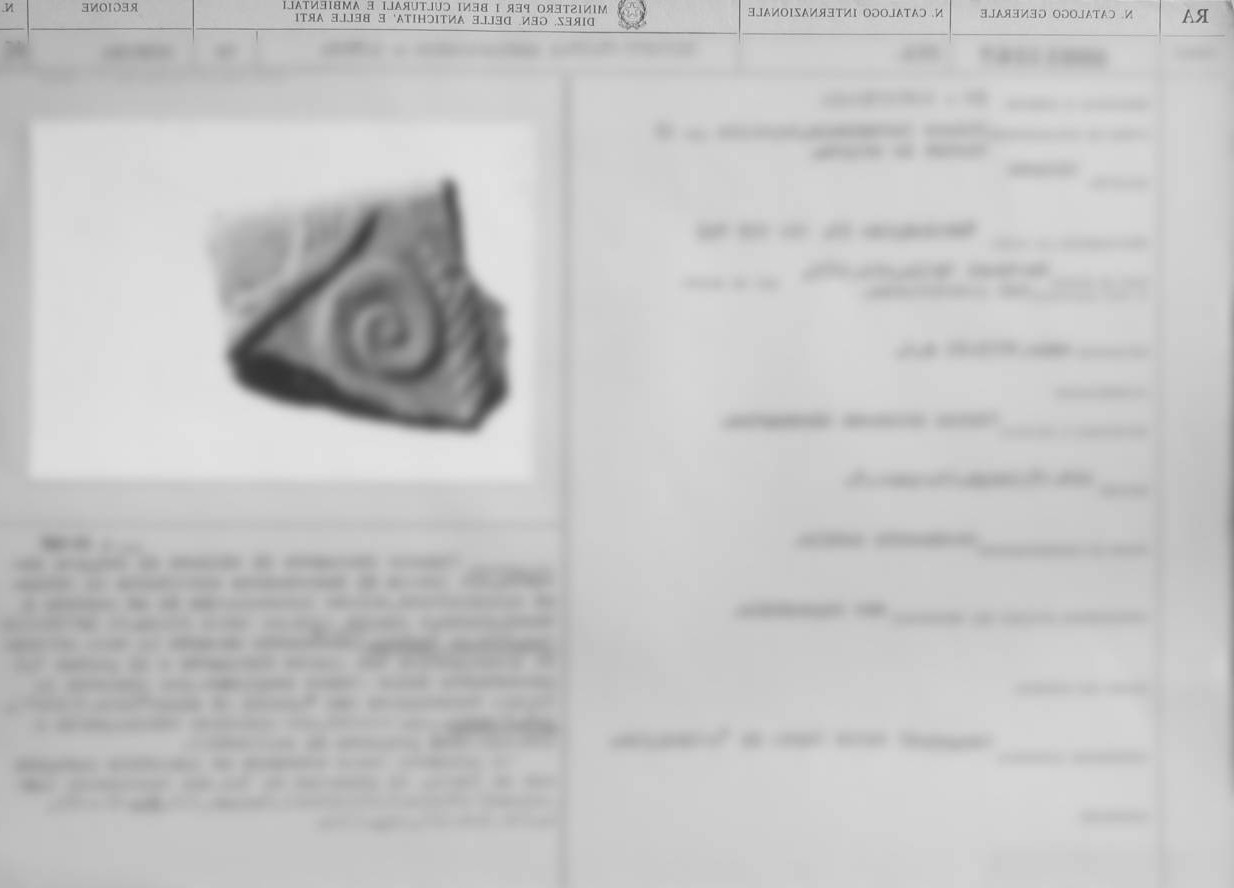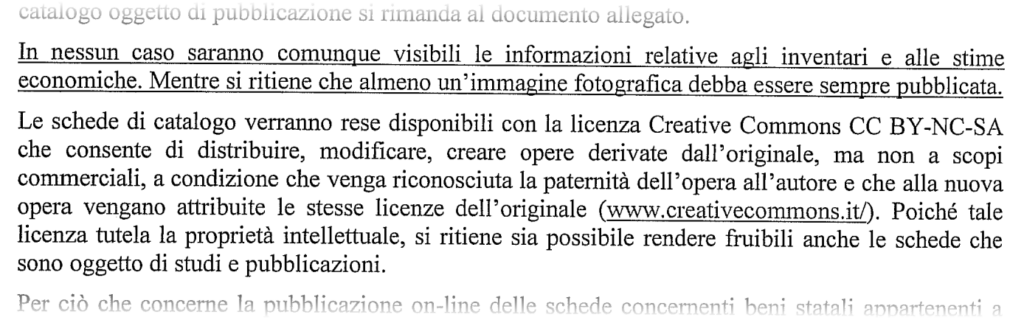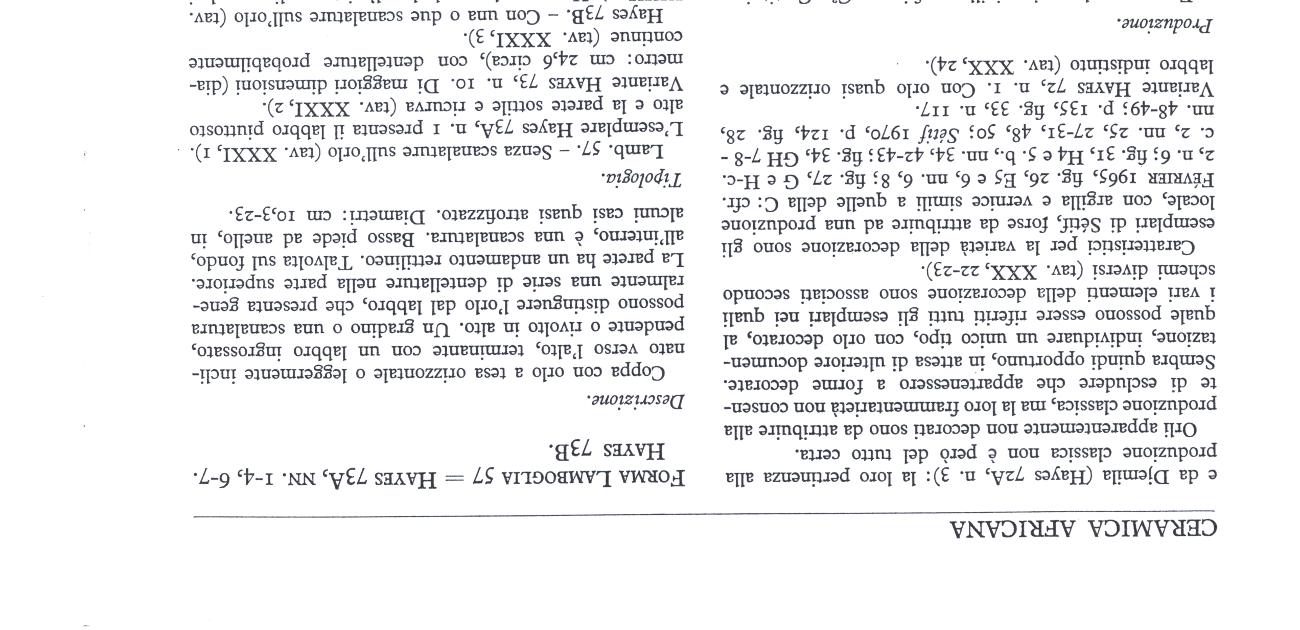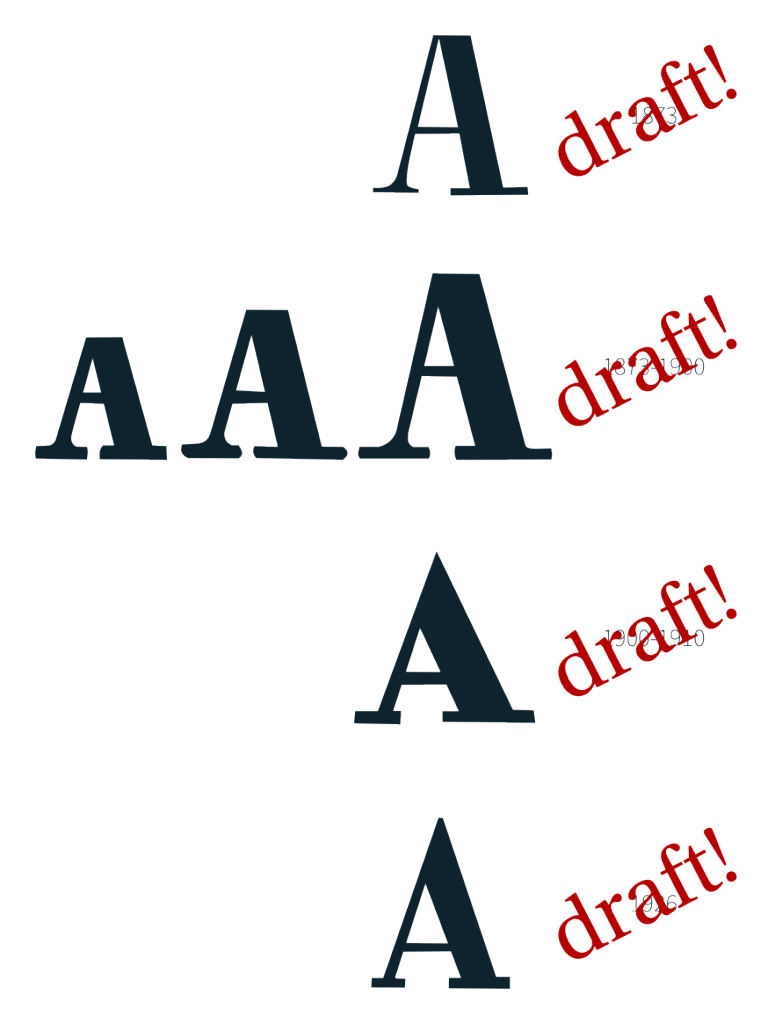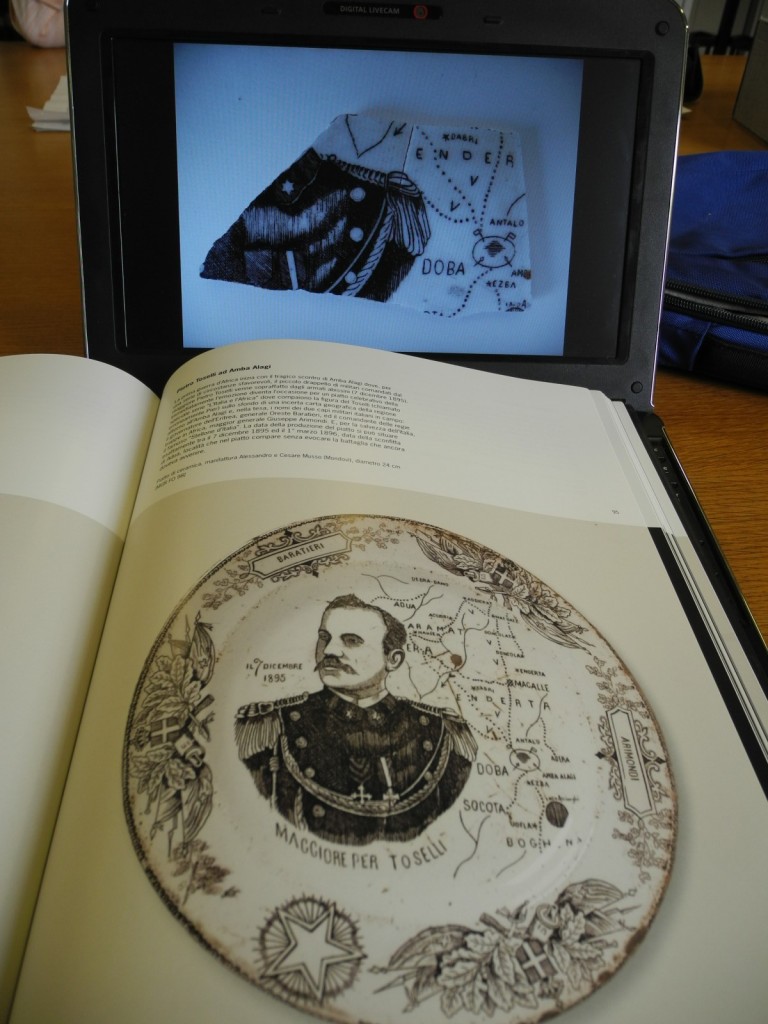Nella bozza di decreto con DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO compare come è noto anche la voce Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici, che contiene tre norme diverse, del tutto slegate tra loro e a mio parere sintomo di una incapacità politica di leggere il mondo dei beni culturali.
Le tre voci sono le “foto libere”, un indebolimento (ennesimo) delle procedure di autorizzazione paesaggistica e la diminuzione da 40 a 30 anni del termine di consultazione per i documenti giudiziari in archivio. Sui punti 2 e 3 non ho niente da dire. Sul punto 1 ho qualcosa da dire, aggiungendo alle ampie riflessioni di Luca Corsato in cui è spiegato chiaramente che tutti gli usi più credibili e buoni delle immagini dei beni culturali (Wiki Loves Monuments, Invasioni Digitali, OpenGLAM, …) sono completamente esclusi da questo regime di piccole concessioni.
Riporto per intero il passaggio in questione dalla bozza di decreto pubblicata da Tafter:
Sono libere, al fine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose,né l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.”
Quindi il vertice politico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ritiene che lo studio, la ricerca, la libera manifestazione del pensiero, l’espressione creativa e (tremo al pensiero) la promozione della conoscenza del patrimonio culturale siano attività che devono essere primariamente svolte senza scopo di lucro. Ovviamente questo non esclude di esercitarle a scopo di lucro, ma solo con esplicita autorizzazione e, immaginiamo, pagamento. Si dichiara abbastanza chiaramente che:
- l’espressione creativa basata sul più grande e magnifico patrimonio culturale del mondo (come dice chi non ha niente da dire) possa avere scopo di lucro solo se preventivamente autorizzata;
- la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, ovvero molto semplicemente far conoscere agli altri, al mondo, agli amici le cose belle che vediamo in giro, sia ugualmente sottoposta allo stesso regime di preventiva autorizzazione allo scopo di lucro;
- che la ricerca sia alla pari con le altre attività, con buona pace delle decine e decine di imprese che fanno ricerca d’avanguardia sul patrimonio culturale, partecipando a bandi e progetti europei ‒ quasi unico paese in Europa in cui siano vigenti restrizioni di questo genere.
Ma non è tutto, perché passando al punto 2), le “riproduzioni” diventano “immagini” (e quindi immaginiamo che le disposizioni del punto 2 non si applichino alle riproduzioni che non sono immagini, es. le stampe 3D, il testo di un documento copiato in digitale…). Queste immagini possono essere divulgate con qualsiasi mezzo, dalla stampa alla proiezione su maxischermo inclusa la pubblicazione su Internet, solo se nessuno può ulteriormente riprodurle. Evidentemente mancano le basi tecniche fondamentali per capire che quando Tizio pubblica sul suo sito web personale una foto, nel momento in cui Caio la visualizza sul suo computer o tablet ha già creato una copia identica del file sul proprio dispositivo. Inoltre, poiché di fatto la stragrande maggioranza di queste condivisioni avviene tramite social network, le immagini pubblicate sono automaticamente copiate sui server e da lì diffuse attraverso ulteriori copie sui dispositivi di tutti gli utenti che visualizzano le immagini. La stessa indicazione di “utente” è al tempo stesso fuorviante e priva di senso, poiché la maggior parte delle operazioni di elaborazione e trasferimento dei contenuti sono completamente automatiche.
Passando dagli aspetti squisitamente tecnici a quelli di natura contrattuale, facciamo un esempio con Twitter per capire meglio l’assurdità del decreto.
I termini di servizio di Twitter, al punto 5 recitano:
Con l’invio, la pubblicazione o visualizzazione di Contenuti sui Servizi, o mediante gli stessi, l’utente concede a Twitter una licenza mondiale, non esclusiva e gratuita (con diritto di sublicenza) per l’utilizzo, copia, riproduzione, elaborazione, adattamento, modifica, pubblicazione, trasmissione, visualizzazione e distribuzione di tali Contenuti con qualsiasi supporto o metodo di distribuzione (attualmente disponibile o sviluppato in seguito).
…
L’utente accetta che i propri Contenuti potranno essere condivisi, trasmessi, distribuiti o pubblicati dai partner di Twitter e si assume le eventuali responsabilità che possono derivargli qualora non abbia il diritto di fornire Contenuti per detto utilizzo.
Di fatto, la bozza di decreto ci proibisce di pubblicare una immagine di bene culturale su Twitter. Altrettanto di fatto, questa norma viene descritta da tanti (esempio 1, esempio 2) come “libera selfie” o comunque favorevole proprio alla condivisione sui social network. Non capisco bene come sia possibile un fraintendimento così esagerato, sia da parte di chi ha prodotto questo testo sia da parte di alcuni commentatori entusiasti. Siamo, a mio personale parere, di fronte all’ennesima occasione persa di una vera riforma della normativa sulla riproduzione dei beni culturali. Questo fatto potrebbe sembrare strano alla luce della continua e ripetuta importanza strategica dei beni culturali come struttura portante per il rilancio dell’Italia, anche dal punto di vista economico e turistico. Di fatto, ai proclami politici non sembra seguire una adeguata analisi delle richieste del settore. Permane una pretesa di controllo totale, anche nei casi in cui palesemente non sussiste alcuna possibilità di immediata monetizzazione della riproduzione, come nel classico caso del museo in cui non si possono scattare foto ma non è nemmeno disponibile un catalogo stampato da acquistare. In più, viene dato un segnale debole alle istituzioni decentrate, che temo ci porterà dagli attuali bruttissimi segnali “Vietato fotografare” a segnali e/o volantini molto più prolissi in cui saranno spiegate le modalità in cui è possibile chiedere l’autorizzazione a fare una cosa normalissima: fotografare quello che ci piace. E rimarrà quindi nella coscienza collettiva anche una distorsione del tutto inspiegabile, cioè il divieto/obbligo di permesso per scattare foto dentro il museo tout court, laddove la norma è specifica sui beni culturali e non riguarda minimamente il museo come struttura, spesso semplice contenitore di oggetti nonostante idealizzazioni teoriche lontane dalla realtà.
Ciliegina sulla torta: viene concessa la possibilità di riproduzione a bassa risoluzione digitale, con sentite scuse ai possessori di un display retina. Non ci resta che far stampare i nostri selfie a 1200 dpi e distribuirli agli amici e “amici”. Che non potranno nemmeno rivenderli come carta straccia per liberarsene, ma dovranno eliminarli senza scopo di lucro.